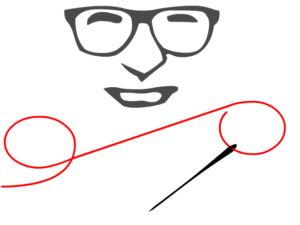
Riflessioni ad alta voce
Dal regionalismo siciliano al macroregionalismo europeo passando per l’autonomismo comunitario
Andrea Piraino*
1.- Per svolgere il ragionamento indicato dal titolo di questa riflessione, mi sembra imprescindibile partire dal regionalismo nato in Sicilia con il Regio Decreto Legislativo n. 455 del 15 maggio 1946. E, poi, anche nelle regioni Sardegna, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige ed infine nel Friuli Venezia Giulia. Il tutto confermato dalla Costituzione Repubblicana e dalle prime Leggi costituzionali entrate in vigore nei primi mesi del 1948.
Questa circostanza non deve indurre, però, a pensare che di Regioni nel nostro Paese si sia cominciato a parlare solo dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia nell’estate del 1943. Di queste istituzioni innovative (rispetto allo Stato, ed ai Comuni e, finanche, alle Province) in Italia se ne dibatteva, infatti, fin dai tempi dell’unificazione, come alternativa sia al modello di “Stato unitario” (accentrato) che al modello di “Stato federale”.
Come è noto, però, con il prevalere della Destra storica il Paese fu indirizzato verso la “forma di stato” accentrato sul modello napoleonico francese. Ne conseguì che, per circa mezzo secolo, in Italia di regionalismo non si discusse quasi più! Tranne, naturalmente, in ristretti circoli culturali progressisti che, con i loro dibattiti, ne mantenevano viva la memoria.
Fu con l’avvento sul proscenio della politica nazionale di don Luigi Sturzo che il tema delle Regioni ritornò ad interessare l’opinione pubblica democratica e la politica fino al punto da far sostenere al sacerdote di Caltagirone, nel corso della sua relazione (dal titolo “Il decentramento amministrativo, le autonomie locali e la costituzione della regione”) al terzo Congresso del Partito Popolare Italiano (PPI), celebratosi a Venezia nei giorni 20/23 ottobre 1921, che quest’ultimo era nato proprio per trasformare lo Stato italiano accentrato in uno Stato regionale.
Da allora, la prospettiva regionale fu all’odg. dell’agenda politica del Paese: prima, per essere combattuta ferocemente dal fascismo e, poi, per essere adottata e concretizzata dalla Costituzione democratica introdotta a seguito della lotta di liberazione nazionale.
2.- All’inizio di questa ‘storia’ del regionalismo -dunque, come accennato- vi fu per ben due volte la Sicilia! La prima perché, tramite il pensiero e l’azione illuminata di uno dei suoi figli più illustri (Luigi Sturzo), ne definì non solo la formula politica ma anche l’ordinamento istituzionale. La seconda perché, consapevole della propria identità storica e dell’autogoverno goduto nei secoli precedenti, all’indomani dello sbarco degli Americani a Gela, Licata e nelle altre località marine della sponda sud della Sicilia il 9 luglio 1943, insorse in un moto popolare per rivendicare l’indipendenza dall’Italia e l’autodeterminazione dei propri Popoli.
La vicenda, com’è noto, ebbe risvolti anche drammatici. In particolare, perché il Movimento Indipendentista Siciliano (MIS) -che aveva, al proprio interno, due ‘anime’: quella oltranzista (di Antonio Canepa) che premeva per una vera e propria secessione e quella federalista (di Andrea Finocchiaro Aprile) più moderata e prudente- a seguito della prevalenza della prima sulla seconda imboccò la strada militare dello scontro armato con lo Stato che fece registrare tutta una serie di episodi cruenti e manifestazioni violente fino all’eccidio (nella Cittadina catanese) di Randazzo del 17 giugno 1945 dove furono massacrati alcuni militanti dell’EVIS (Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia) ad opera di una pattuglia di Carabinieri appostati nei pressi del bivio per Bronte (altro Comune della cintura di Catania).
Quale che sia stato il modo in cui si svolsero questi fatti dei quali il quotidiano progressista di Palermo L’Ora scrisse trattarsi di “Una strage di Stato”, il dato storico rimasto è che la Sicilia, dopo meno di un anno dai suddetti eventi, il 15 maggio 1946, come ricordato, con Regio Decreto Legislativo n. 455 ottenne il proprio Statuto che ne riconosceva l’identità regionale e ne sanciva l’autonomia di governo all’interno della adottanda “nuova Costituzione dello Stato” con la quale, poi, avrebbe dovuto essere coordinato.
3.- E qui siamo all’Assemblea costituente eletta, dopo la Liberazione del Paese dal fascismo, il 2 giugno 1946 ed alla Costituzione repubblicana che, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, definisce una inedita “forma di stato” che non consiste più in un unico ed accentrato soggetto istituzionale: lo Stato, appunto; ma, come recita l’art. 114, in una organizzazione policentrica che vede la Repubblica costituita, oltre che dallo Stato, dai Comuni, dalle Province (poi, a seguito della riforma del 2001, anche dalle Città metropolitane) e dalle Regioni, quali nuovi soggetti di un ordinamento paritario.
In concreto, queste ultime vengono individuate in 20 enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni definiti dai principi e dalle regole fissate dalla Costituzione medesima. Nello specifico, 5 di esse (la Sicilia, la Sardegna, la Valle D’Aosta, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia) dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Mentre le altre 15 Regioni, cd. a statuto ordinario, invece, sono organizzate ed esercitano le funzioni loro riconosciute secondo un modello omogeneo stabilito nel Titolo V° della Costituzione.
Al di là delle singole peculiarità che pur sempre vengono mantenute, però, nell’attuazione storica concreta i poteri che sono riconosciuti ai due tipi di Regione e che con il loro processo implementativo hanno comunque determinato lo stravolgimento del vecchio ordinamento dello Stato unitario avviando la nascita della organizzazione pluralistica della Repubblica -a seguito della trasformazione culturale, sociale ed economica pressoché omogenea della società nazionale ed anche della evoluzione politico-costituzionale simile delle istituzioni- subiscono una sorte di processo di uniformazione che rende sempre meno marcata la loro differenza. Anzi, come vedremo, sotto alcuni aspetti, rafforzando la cifra di forza dei poteri delle Regioni a statuto ordinario.
4.- Intanto, non è superfluo ricordare quali siano questi poteri che la Costituzione ripartisce tra lo Stato e le Regioni. A cominciare dalla potestà legislativa che la Carta attribuisce a queste ultime secondo vari tipi che vanno dalla potestà esclusiva (o primaria) a quella residuale (naturalmente, prevista solo dalla riforma del Titolo V° ad opera della legge costituzionale 3 del 2001), e da quella concorrente a quella integrativa. Non solo. Ma, a complemento di questa potestà legislativa, veniva poi ampiamente riconosciuta la potestà amministrativa attribuita alle stesse Regioni per le materie nelle quali avevano potestà legislativa (salvo quelle di interesse esclusivamente locale attribuite dalle leggi della Repubblica ai Comuni, alle Province ed agli altri Enti locali).
Inoltre, a garanzia della possibilità di esercitare questi poteri, si aggiungeva il riconoscimento dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa con la connessa possibilità di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Insomma, una vera e propria rivoluzione che purtroppo, però, forse per la sua eccessiva innovatività costrinse le Regioni a statuto ordinario a segnare il passo per ben 22 anni. Fin quando, cioè, il 7 giugno 1970 -dopo l’adozione della legge elettorale 17 febbraio 1968 n. 108 e di quella finanziaria del 16 maggio 1970 n. 281 che ne rendevano possibile il funzionamento dell’intero apparato- si tennero le elezioni dei Consigli regionali.
E così, finalmente, con l’insediamento degli organi politici e l’organizzazione dell’apparato amministrativo le Regioni ordinarie si affiancavano a quelle speciali e rendevano completo l’ordinamento regionale della Repubblica.
5.- La svolta nell’ordinamento istituzionale fu evidente e attivò grande fervore innovativo e voglia di cimentarsi da parte delle nuove istituzioni con gli importanti problemi delle comunità locali e della grande legislazione del Paese che non sembrava più in grado di regolarne adeguatamente il caotico e contraddittorio processo di sviluppo.
Ben presto, però, anche a causa della pervicace volontà dello Stato di mantenere intatte le proprie tradizionali prerogative di indirizzo politico unitario e di comando regolativo della società dall’alto, l’assestamento istituzionale delle Regioni si indirizzò verso una configurazione più da ente di amministrazione e gestione (delle decisioni assunte dallo Stato) che da soggetto autonomo e responsabile di un proprio indirizzo politico e di una propria programmazione strategica.
Facendo così venir meno, quasi completamente, quella capacità di esercitare la spinta innovativa non solo dell’apparato dei pubblici poteri ma anche della società civile che era stata alla base prima del riconoscimento delle Regioni con la Costituzione repubblicana e poi della loro concreta attuazione nell’ordinamento italiano.
6.- A questa situazione sempre più inadeguata e deludente per il mancato rinnovamento istituzionale che si doveva registrare, finalmente, reagì prima la cultura politico-istituzionale e poi la stessa politica che riscoprivano negli anni ‘90 del secolo scorso il principio di sussidiarietà. In base al quale, ribaltando la logica centralistica di attribuzione e distribuzione del potere, si sottolineava che quello amministrativo potesse essere esercitato dalle Regioni soltanto qualora le Istituzioni locali (Comuni, Province e, poi, Città metropolitane) non si fossero dimostrate adeguate.
Fu lo stimolo per riprendere il cammino innovativo dell’organizzazione dei pubblici poteri nel nostro Paese che, come è noto, si concretizzò nella famosa riforma del Titolo V° della Costituzione (operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001) e nella modifica dei vari Statuti speciali.
Interventi che collocavano visibilmente le Regioni (assieme agli altri Enti locali) al centro del sistema istituzionale della Repubblica e trasformavano lo Stato in un ente funzionale non più sovraordinato rispetto alla posizione ed alle funzioni delle altre istituzioni.
7.- Ma fu un altro clamoroso flop! Questa volta , però, più per responsabilità dello Stato e della politica nazionale che, approfittando di alcune incongruenze della stessa riforma costituzionale del Titolo V°, cominciarono subito a remare contro riproponendo con la legge n. 131 del 2003 (cd. “La Loggia”) un modello di governance accentrato, limitativo dei poteri legislativi delle Regioni e, soprattutto, dimentico dell’autonomia finanziaria, affidata ad un legge di delegazione (la n. 42 del 2009) che per buona parte è rimasta ancora da attuare.
A ciò bisogna, poi, aggiungere, la giurisprudenza restrittiva, circa il riconoscimento di più ampi poteri alle Regioni, della Corte costituzionale che con varie sentenze dei primi anni successivi alla riforma confermava l’orientamento dello Stato e delle maggioranze che lo reggevano.
Infine, questo indirizzo sfociava in due tentativi, sostenuti con forza e decisione da due maggioranze opposte, di una nuova riforma costituzionale miranti entrambi ad una più o meno spiccata modifica del regionalismo in favore di un riaccentramento di poteri nello Stato che, però, fortunatamente furono entrambi respinti dalla saggezza del Corpo elettorale con i referenda del 2006 e del 2016.
8.- Sulla scia dell’opinione pubblica più consapevole, queste circostanze scuotevano però la politica regionale ed attivavano le Regioni del Centro-Nord -nello specifico quelle di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna- che, facendo riferimento alla nuova norma del terzo comma dell’art. 116 della Costituzione che prevede la possibilità di attribuire alle Regioni “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” in svariate materie elencate nel secondo e terzo comma dell’art. 117 Cost., avviavano, sentiti i loro enti locali, la procedura per questo maggiore riconoscimento di poteri attraverso la stipula di una intesa con lo Stato da approvare con legge a maggioranza assoluta.
L’iniziativa, però, un po’ per le incertezze procedurali palesate dai vari Governi nazionali e molto per l’impostazione sbagliata impressa alle loro richieste dalle Regioni -che, inizialmente, ne avrebbero voluto fare (il Veneto e la Lombardia, in particolare,) uno strumento per negare il di più di gettito finanziario che versavano alle casse dello Stato a motivo di una contribuzione proporzionale al loro reddito interno- ha sollevato una vera e propria rivolta da parte di moltissime altre Regioni, in specie, quelle del Mezzogiorno che hanno visto in questa azione delle Regioni del Centro-Nord una mancanza di solidarietà nei loro confronti ed una volontà di chiusura alle necessità di rinascita del Sud e con essa dell’intero Paese.
In definitiva, un vero e proprio boomerang che ha spaccato lo stesso Movimento regionalista e che, inoltre, dall’azione di contrasto alla pandemia del Covid 19 e dal decisionismo indiscutibile dei vari Governi, veniva ampiamente ridimensionato e ridotto in posizione subalterna allo Stato, finendo con il doversi accontentare nella fase attuale della semplice partecipazione alla Cabina di Regia ed all’attuazione delle Missioni e dei Progetti stabiliti dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (PNRR) sotto la guida del Governo nazionale.
Naturalmente, se stabilizzato questo ridimensionamento del regionalismo farebbe segnare la fine del suo apporto originale al sistema unitario e democratico della Repubblica e sancirebbe la sua incapacità di provvedere alle esigenze dello sviluppo socio-economico delle Comunità e dei Territori. E ciò proprio quando, invece, necessita un grande rilancio ed un forte sviluppo di un nuovo Regionalismo! Che non può incentrarsi esclusivamente e, neppure, prioritariamente sulla governance (e i suoi modelli) ma deve concernere innanzi tutto gli altri due ‘elementi’ che costituiscono l’organizzazione fondamentale delle istituzioni regionali e cioè i territori e le comunità che li abitano.
9.- E’ tutto qui il grave errore del Regionalismo differenziato e della battaglia del ministro Calderoli e della sua legge n. 86 del 2024!
Invece, di indirizzare la propria spinta al cambiamento verso una nuova organizzazione territoriale per risolvere il principale problema del dimensionamento che oggi angustia tutte le istituzioni regionali che sono prive di un qualsiasi livello territoriale ottimale per l’esercizio delle funzioni e la erogazione dei servizi alle comunità, si occupa esclusivamente del potere. Della cifra di potere, cioè, che le Regioni devono sottrarre alla sovranità dello Stato e, poi, singolarmente che ogni Regione vuole fare valere nei confronti delle altre. Per il resto -delle dimensioni e delle esigenze dei territori, della loro adeguatezza per garantire un esercizio unitario delle funzioni e, soprattutto delle comunità con le loro storie, culture, relazioni economico-sociale, diritti, doveri- nessuna considerazione e preoccupazione. Soltanto pretese di potere, in una sorta di delirio rivendicativo, per mantenere un effimero consenso elettorale.
Il tutto sapendo peraltro bene che, fin dal momento del suo riconoscimento in sede di Assemblea costituente e della sua definizione nell’art. 131 della Costituzione, il regionalismo italiano ha dovuto subire una costrizione in confini impropri, seppure tradizionali, dettati dalla necessità di evitare di rivivere pericolose situazioni storiche faticosamente superate nel tempo e di accogliere le richieste di ispirazione populista formulate dai Partiti politici che dopo il secondo conflitto mondiale invocavano Regioni più piccole di quelle “di cui alle pubblicazioni ufficiali statistiche” per farle corrispondere meglio agli interessi degli stessi rappresentati loro elettori. Riuscendo, in questo modo, sì al istituirle come nuove entità politiche accanto allo Stato e ai Comuni ma lasciando completamente irrisolto il problema del loro dimensionamento territoriale sulla base di criteri funzionali e di tipo economico-finanziario, che fin da allora avrebbe portato a Regioni più ampie di quelle corrispondenti alla configurazione prevista dei dipartimenti statistici e cristallizzata nella Costituzione.
Né si può dire che di questa circostanza non vi sia stata successivamente consapevolezza nella politica istituzionale del Paese. Perché già nella prima metà degli anni ‘70 del secolo scorso, subito dopo l’istituzione delle Regioni ordinarie, il primo presidente dell’Emilia Romagna, Guido Fanti, e l’allora semplice deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, Piersanti Mattarella, assunsero delle iniziative tese a superare la frammentazione e l’inadeguatezza delle Regioni tradizionali al fine di costruire l’alternativa allo Stato burocratico-centralista. Fanti proponendo un accordo permanente tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e, naturalmente, Emilia Romagna per sostenerne la costituzione di una unitaria Macroregione. Mattarella lanciando l’idea (poi accolta nella legge n. 183 del 1976) di istituire tra le Regioni del Sud un Comitato di rappresentanti che le rendesse unitariamente partecipi della programmazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno. Senza dimenticare, naturalmente, tra questi pionieri il grande pensatore “cisalpino”, Gianfranco Miglio, che sosteneva la necessità di superare le Regioni storiche con la creazione di un’autonoma Macroregione del Nord, motivata da “ragioni di natura storica, politica, istituzionale, a cominciare dalla ‘pietosa’ esperienza dello stato unitario che, dal punto di vista burocratico ed amministrativo, ha sempre funzionato poco e male”.
E non finisce qui. Perché con la crisi della cd. “Prima Repubblica”, la Fondazione Agnelli, a seguito della ricerca: La Padania, una regione italiana in Europa, lancia la proposta di istituire macro-aree economiche a vocazione europeista come alternativa al regionalismo amministrativo e burocratico attuatosi in Italia e criticato dall’emergente politica della Lega Nord che prospettava di rinnovare l’architettura istituzionale del Paese organizzandolo in “tre Italie”.
10.- Seppure timidamente, la risposta a queste istanze per una nuova perimetrazione dei territori regionali arrivava con la riforma del Titolo V° della Costituzione che non introduceva solo la norma dell’art. 116 comma 3 ma anche l’ottavo comma dell’art. 117 che apriva ad una nuova visione comunitaria del regionalismo e stimolava tra l’altro diverse iniziative legislative di svariati parlamentari. Da Roberto Morassut e Raffaele Ranucci -che prevedevano un riordino territoriale delle venti Regioni elencate nell’art. 131 Cost. per accorparle in dodici zone omogenee secondo piani che tengano conto delle funzioni che devono svolgere- a Roberto Maroni che proponeva l’unificazione delle Regioni padane in vista della costituzione in ambito europeo della “Macroregione alpina”; da Stefano Caldoro, che invitava il Presidente del consiglio, Matteo Renzi, a valutare una riforma dello Stato articolata in cinque Macroregioni, al Presidente della Regione Marche, Gianmario Spacca, che sosteneva che l’articolazione della Repubblica in Macroregioni avrebbe costituito uno strumento politico importante per avere più voce in Europa.
Insomma, il riformismo regionalista almeno dalla riforma del Titolo V° ha avuto consapevolezza della necessità di un nuovo dimensionamento territoriale delle Regioni. Ma ciò, lungi dal suggerire a Calderoli ed all’attuale Governo di connettere l’iniziativa per “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” a questa nuova prospettiva territoriale facendone uno strumento di riattualizzazione delle funzioni, delle reti e dei servizi attribuiti alle Regioni, li ha vieppiù spinti a legarla alla esclusiva dimensione del potere e del consenso, senza rendersi conto che la base di legittimazione di questi ultimi è innanzi tutto lo spazio nel quale essi si manifestano e si esercitano.
Né a tal fine possono essere evocate le perplessità suscitate dalla considerazione che, poiché nella prospettiva funzionale le articolazioni territoriali non sono immobili ma devono essere aggiornate continuamente con “l’evolversi della intelaiatura economia, delle strutture sociali, delle condizioni culturali”, le Regioni vedrebbero minata la loro stabilità politico-istituzionale. E ciò perché se un carattere ha sempre distinto fin dalla loro nascita le Regioni esso è stato proprio quello della loro mobilità. Lo conferma, tutto ciò, il tentativo di ancorarle alla programmazione che se pure, secondo alcuni, è sostanzialmente fallito, ne ha evidenziato sicuramente la vocazione dinamica e quindi la capacità di adattarsi alle esigenze del cambiamento.
Cambiamento che troverebbe poi le forme della sua stabilizzazione , come previsto dall’ottavo comma dell’art. 117 della Costituzione, tramite il meccanismo, ratificato dalla legge regionale, dell’intesa di una Regione con altre Regioni, “per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”.
E qui si appalesa in tutta la sua portata la possibilità di costituire dal basso Macroregioni per esercitare al meglio funzioni comuni proprie delle Regioni che soltanto successivamente potrebbero legittimare la richiesta di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. Circostanza, questa, che la legge Calderoli ignora totalmente. Mentre condiziona l’attribuzione di ulteriori funzioni autonome “alla determinazione […] dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”. Ma con la precisazione che essi non devono comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il che significa che la pregiudizialità dei LEP si fermerà alla loro semplice “determinazione” e che difficilmente saranno finanziati. Verrebbe da dire un semplice bluff !
11.- Detto questo, non bisogna trascurare, però, l’altro profilo che la prospettiva di questo nuovo regionalismo comunitario, alternativo a quello della semplice differenziazione, conduce con sé. E cioè che esso non serve solo per ridisegnare l’organizzazione istituzionale del Paese ma deve essere anche e soprattutto funzionale a gettare le basi di quell’Europa politica che non può che essere delle Comunità regionali e quindi, come dicevano i Padri fondatori, dei Popoli e non più degli Stati!
Può sembrare azzardato affermarlo quando ancora la logica intergovernativa guida le politiche europee e sovranismo e populismo sembrano prevalere su tutte le istanze comunitarie. Ma è proprio così! Se non si accantona il pensiero centralista e tecnocratico che ha dato vita all’attuale struttura burocratica degli Stati, priva di anima e senza futuro, l’impronta economicistica dell’Europa non sarà mai superata e la moneta unica si sostituirà all’unità culturale, sociale, politica ed economica che costituisce la vera ragione d’essere della sua fondazione. Confermando quello che sostiene qualcuno che l’Unione Europea non ha saputo fronteggiare né la devastante crisi economica degli ultimi decenni né l’appiattimento delle culture storiche ed ha lasciato i suoi cittadini smarriti.
Ma fortunatamente non è così, intanto, per le comunità degli otto Paesi ufficialmente candidati all’adesione e, in modo più significativo, per i “Grandi della Terra” che, dopo la pandemia e l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, hanno dovuto constatare che l’Europa con i suoi valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto non solo esiste e per difenderli è pronta a fare sacrifici e rinunce, ma anche che può giocare un ruolo importante nella sfida globale per la costruzione di un pluriverso pacifico e cooperativo.
Ora, se tutto quanto appena detto è vero, ciò che ne deriva è che la prospettiva di un nuovo regionalismo non può restare relegata alla dimensione dell’organizzazione funzionale interna ma deve misurarsi con la prospettiva della costruzione della nuova politica macroregionale del vecchio Continente. Non avrebbe senso, infatti, pensare che basti un aumento degli spazi di autonomia per consentire che le Regioni nazionali possano navigare nell’oceano dei nuovi rapporti geo-politici del mondo globalizzato. Il mondo delle microregioni autoreferenziali, degli stati e degli staterelli chiusi -in un futuro che, come sostengono da tempo Michael Hardt e Antonio Negri, semmai sarà caratterizzato dal ritorno del dominio degli Imperi– è inesorabilmente finito, cancellato dalla logica delle grandi strategie planetarie.
12.- Del resto è bene chiarire subito che le Macroregioni in proiezione europea non costituiscono un nuovo soggetto istituzionale bensì sono l’espressione di un strategia che l’Unione Europea adotta “nell’ambito del più generale obbiettivo della cooperazione territoriale che rappresenta, a sua volta, […] un laboratorio sperimentale dell’integrazione europea”. Con essa si spera, cioè, di migliorare l’equilibrio geografico dello sviluppo economico e di innalzare il tasso potenziale di crescita dell’intera Unione, rendendolo sostenibile, equilibrato e armonioso, in grado di ridurre le diseguaglianze tra le diverse Regioni europee e di rafforzare la cooperazione transfrontaliera, mediante iniziative congiunte locali e regionali, e la cooperazione transnazionale per mezzo di azioni volte allo sviluppo locale.
Insomma, le Macroregioni sono strumenti per la migliore attuazione della coesione territoriale e per la promozione di uno sviluppo “in grado di superare i confini fra gli Stati-membri”. Rendendo più efficace “un’azione che veda come protagoniste aree territoriali contigue, accomunate da problematiche simili, piuttosto che interi territori statali, considerati separatamente l’uno dall’altro”. In sostanza, il valore di tale prospettiva macroregionale nasce dall’abbattimento e dal superamento dei confini politico-amministrativi entro cui, ad oggi, restano relegati e sono costretti gli Stati, le Regioni (nazionali) e tutti gli antri Enti territoriali.
Il che implica che qualsiasi forma di collaborazione e di cooperazione tra territori per affrontare gli attuali problemi dell’ambiente, dello sviluppo, delle comunicazioni, delle politiche sociali, etc. dipende dal capovolgimento proprio di questo concetto di confine: da luogo del limite, del muro, del divieto di oltrepassamento a sede dell’incontro, della collaborazione, della cooperazione e, finalmente, della condivisione e dell’integrazione. Ritornando al vero significato del concetto di confine che, prima di evocare la linea di separazione di due spazi, di due territori, di due Città, di due Paesi, indica la linea comune (cum-finis) in cui si verifica l’incontro fra due realtà diverse che così non vengono separate ma unite. Seguendo l’insegnamento della natura che non conosce discontinuità. Mentre qualsiasi separazione, qualsiasi limite è del tutto convenzionale.
Così si potranno avere delle Macroregioni frutto di iniziative innovative di concertazione, collaborazione e integrazione , che non si fermino ai confini dei territori del nostro spazio nazionale ma coinvolgano le aree limitrofe dei Paesi viciniori che condividono gli stessi problemi, ad esempio, di sviluppo.
13.- In conclusione, come dimostra anche la normativa europea con il suo sostegno alle strategie macroregionali, il regionalismo storico ha ormai esaurito la sua iniziale spinta innovativa dell’organizzazione dello Stato e una nuova fase propulsiva non può che essere data dalla costruzione di Macroregioni funzionali poiché gli attuali perimetri amministrativi delle Regioni non consentono di risolvere alcun problema e, soprattutto, di gestire in modo efficiente, efficace ed economico alcun servizio pubblico a favore delle cittadinanze.
Non si tratta di un’operazione facile, perché le nostre istituzioni regionali sono troppe ed un intervento per accorparle in entità più adeguate alle funzioni che sono chiamate a svolgere genera forti resistenze e molti tentativi devianti come quello del regionalismo differenziato che, invece, della funzionalizzazione alla costruzione di strategie macroregionali viene utilizzato per acquisire ulteriori slot di potere da impiegare al fine di realizzare una sorte di torsione federalista di tipo impropriamente competitivo che porterebbe, come è stato scritto, alla divisione del Paese ed alla “secessione dei ricchi”.
Ma senza scalfire una certezza! Che una articolazione frammentata delle comunità sul territorio nazionale non è sempre e comunque preferibile, anche per le realtà più forti, di una aggregazione in più ampie collettività di individui che condividono una storia ed una condizione umana. Soprattutto in un Paese come il nostro assai differenziato per storie e realtà regionali, così diseguale nei livelli di reddito e, come abbiamo visto, così diverso anche nelle scelte relative ad una auspicabile nuova organizzazione regionale.
*Professore di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Palermo
