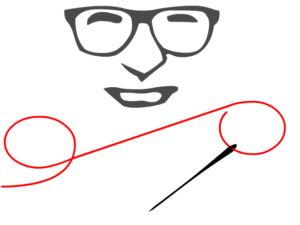
Riflessioni ad alta voce
Carcere e diritti della persona in stato di detenzione
Carlo Alberto Romano*
L’unico riparo, nel tormentato mare della negazione dei diritti della persona in stato di detenzione, rimane l’art. 27 c. 3 della Costituzione, il cui nucleo fondamentale risiede nel concetto (allora così definita) di “rieducazione”; fragile riparo, contro il quale i potenti marosi della retributività (in realtà alter ego di una tanto diffusa quanto poco sopita volontà vendicativa) sembrano spesso prevalere trovando forza e ragion d’essere nell’imperioso vento securitario che, da almeno un paio di decenni, soffia del tutto noncurante di ogni divergente lettura del fenomeno criminale.
Il concetto costituzionale di “rieducazione”, oggi veicolato da attente ed equilibrate letture, sia interne al sistema giudiziario sia esterne, poggia la propria consistenza sull’idea di rielaborazione del reato da parte del reo, di riflessione sulla propria condotta criminale e di conseguente impegno nel percorso trattamentale scaturente dai due antecedenti e necessari passaggi.
Un meccanismo apparentemente granitico, figlio di un pensiero libero e partecipato che, anche sulla scorta della propria tragica esperienza, seppe fissare nella Costituzione un’idea di pena opposta all’uso che ne fece il regime fascista da cui ci affrancammo con quella Resistenza che ostinate e crudeli carcerazioni non riuscirono a piegare. Eppure fragile.
il sistema penitenziario pare infatti possedere una spiccata capacità per comprimere (e talvolta sopprimere) diritti che invece dovrebbero semplicemente esistere; a partire dall’attuale (ma certo non recente) situazione di sovraffollamento che, strutturalmente, rende disagevole ogni forma di convivenza tra principi rieducativi e condizioni quotidiane di vita inframuraria, proponendo, per ciò stesso, una pena aggiuntiva alla privazione della libertà che, a pena eseguita, consegnerà a chi esce dal carcere abbondanti dosi di astio e frustrazione, corposi ingredienti aggiuntivi di un già di per sé ipernutrito rischio di recidiva.
Evocare il sovraffollamento significa richiamare alla mente una situazione tendenzialmente emergenziale e che, invece, se si eccettua la breve parentesi parentesi del Covid-19, rappresenta la normalità del nostro sistema penitenziario.
D’altra parte l’assuefazione al termine sovraffollamento molto ci dice sulla invalsa e diffusa tolleranza alla condizione di affollamento (che pure non dovrebbe essere considerato come accettabile) e sulle concrete valutazioni risolutive, nonostante il fatto che il nostro sistema si stia nuovamente avvicinando a quel valore apicale di presenze (raggiunto agli inizi della seconda decina del duemila) che aveva determinato le condanne della Corte europea dei diritti umani.
Affermare che il carcere rappresenti un luogo di negazione dei diritti fondamentali e specifici non è certo una novità dirompente. Ricordare come ciò produca concrete sofferenze fisiche e psicologiche, testimoniate anche da un profondo isolamento strutturale e personale del carcere stesso è comunque opportuno, laddove a tale considerazione si unisca la tragica constatazione delle quasi 2000 persone che si sono tolte la vita, in carcere, solo nel terzo millennio e delle oltre 50 suicidatesi fino a oggi, nell’anno in corso.
O laddove si voglia sottolineare come in carcere, negli ultimi anni, si sia appalesata la presenza di patologie psichiatriche la cui difficoltà di presa in carico, in un ambiente del tutto inidoneo, risulta facilmente comprensibile.
Per tacere della gestione delle persone straniere, per la quali il contesto culturale e linguistico di provenienza presupporrebbe la presenza di operatori formati ad hoc, invece drammaticamente assenti o del tutto insufficienti.
Un altro fondamentale diritto negato riguarda la gestione dell’affettività, un concetto che, in carcere, contempla due importantissimi aspetti: la tutela della relazione affettiva in genere (e della genitorialità in particolare), e la tutela (o il consenso all’esercizio) della sessualità. La recente sentenza n. 10/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del divieto assoluto di colloqui intimi tra detenuti e familiari, ribadendo quindi quel diritto all’affettività e alla sessualità già disposto con la sentenza n. 301/2012.
La Corte ha convintamente affermato come l’esercizio all’ affettività sia un diritto da garantire. Ma poiché ciò, come può ben comprendere chiunque, può avvenire solo con la collaborazione di tutte le parti interessate, dalla persona detenuta all’amministrazione penitenziaria compresa la Magistratura di sorveglianza, anche rispetto all’attuazione di questo diritto troviamo più situazioni di stallo che proposte risolutive, con orientamenti che traducono in comodo immobilismo la pregiudizialmente paventata impossibilità di reperire soluzioni al pieno ’esercizio dell’affettività in carcere.
Cosa rimane di dire e da fare, in questa situazione?
Di fronte all’offensiva di un modello di pensiero tendente al “buttar via le chiavi”, credo che spetti alla comunità l’obbligo di invertire la rotta.
Occorre riavviare un impegno collettivo di impronta soprattutto culturale che coinvolga la comunità nella gestione dell’esecuzione penale, e non solo come luogo di svolgimento alternativo della detenzione, ma soprattutto come protagonista nel propugnare una cultura della pena che non ritenga imprescindibile la componente afflittiva della pena e che, invece, spinga per potenziare l’ingresso della cultura in carcere, capisca il valore delle esperienze d’integrazione con la scuola, porti la formazione in carcere, e porti fuori le persone detenute, nei luoghi della formazione, a partire dalle università che possono svolgere un ruolo fondamentale in questa prospettiva. L’intervento del territorio appare essenziale anche nel rendere fruibile il diritto al lavoro, sia trovando opportunità occupazionali, infra ed extrumurarie, sia reperendo alloggi esterni idonei, per le persone che non ne dispongano.
Interrogarsi sulla negazione dei diritti in carcere, primo fra tutti il diritto a un idoneo trattamento significa cominciare a ragionare sulle cause dell’elevato valore di recidiva di chi esce dal carcere, inevitabile conseguenza della resa di campo all’affermarsi di condizioni assolutamente non in grado di soddisfare l’obiettivo costituzionale,
In questa prospettiva, il coinvolgimento relazionale della comunità esterna appare un passaggio imprescindibile e, all’interno di tale cornice, l’apporto che risorse di valore, singole o associate, decidono di portare direttamente dentro il carcere può diventare uno strumento di riconoscimento e affermazione dei diritti che il sistema tende invece a comprimere o negare.
Ma su questo, direi che l’esempio del Presidente Onida, possa valere più di ogni ulteriore parola.
*Professore associato di Criminologia e Criminologia penitenziaria, Università degli Studi di Brescia
